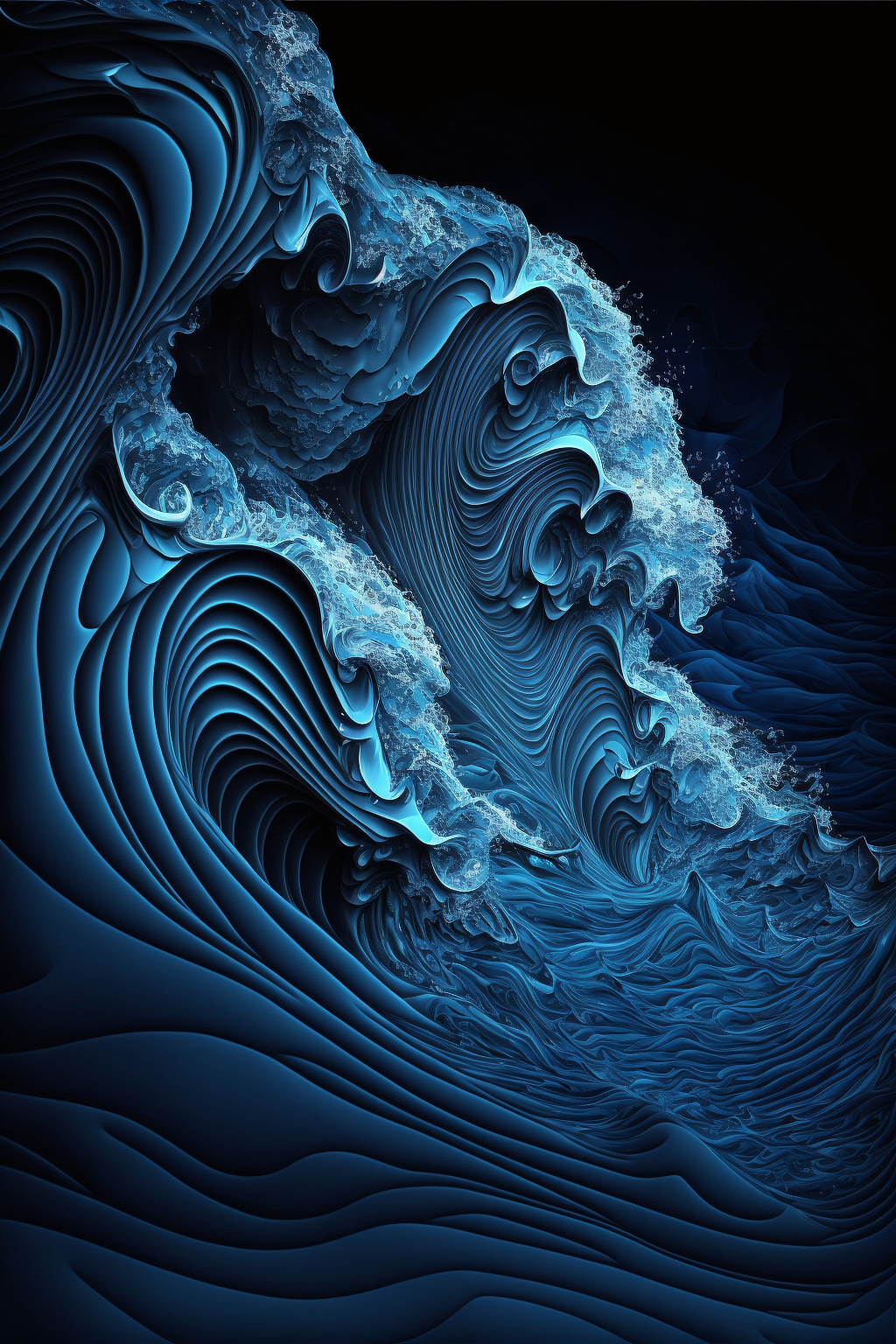La nozione di «forza»
«Il vero eroe, il vero soggetto, il vero centro dell’Iliade è la forza… la forza è ciò che trasforma ogni essere vivente che le sia sottomesso in una cosa. Quando essa è esercitata fino in fondo, trasforma nel senso più letterale del termine un uomo in una cosa, rendendolo un cadavere».1
Così inizia il breve testo di Simone Weil (un trentina di pagine circa) sull’Iliade. L’essenza del fenomeno della forza è indicata nella sua capacità di «trasformare ogni essere vivente in una cosa», ossia nel contrario di un essere vivente.
La forza (ma io direi piuttosto «il potere») ha la capacità di far cambiare di stato al vivente. Nella sua forma più violenta, la forza semplicemente uccide: un cadavere non è solo un corpo vivo che non si muove più, è una «cosa» dove prima esisteva un «essere vivente». La vita è l’opposto della morte, e la morte, per un essere vivente, è essere portato al livello di una «cosa». Una «cosa» in senso proprio viene mossa, cade, è spostata da altre cose o da altre forze, ma non è viva: non può morire. Solo un vivente può decadere da questo stato o essere fatto decadere da questo stato per passare al livello di mera «cosa». Uccidere è il punto estremo della violenza perché trasforma gli essere viventi nel loro contrario, ossia in pure e semplici «cose», che poi possono essere seppellite, bruciate, fatte a pezzi, disperse… nessuna di queste cose può essere fatta a un essere vivente senza appunto ucciderlo.
La forza è inebriante perché dà potere: le cose si trasformano sotto i nostri occhi quando vengono sottoposte alla forza, e al limite estremo del suo impiego i viventi, quando vengono uccisi, si trasformano in cose, ossia nel loro contrario. La trasformazione delle cose (e dei viventi in cose, che è il massimo esempio di trasformazione) rende visibile il potere. Le persone credono di disporre della forza, nota Weil, e suppongono di poterne disporre all’infinito: non si rendono conto che, al contrario, anch’essi sono in qualche modo posseduti dalla forza. Infatti, «tale è la natura della forza. Il potere che essa possiede di trasformare gli uomini in cose è duplice e si esercita su due versanti: pietrifica in modo diverso, ma ugualmente, gli animi di coloro che la subiscono e di coloro che la usano punto questa capacità raggiunge il culmine sul campo di battaglia, a partire dal momento in cui questa si avvia verso la conclusione. Le battaglie non si decidono tra uomini che fanno calcoli, progetti, prendono una risoluzione e la eseguono, ma fra uomini spogliati di tale facoltà, trasformati, caduti o a livello della materia inerte che non è che passività, o delle forze cieche che non sono che slancio.»2
Gli uomini sono convinti di poter controllare la «forza» e che essa sia al loro servizio: i guerrieri dell’Iliade sono convinti, quando credono di possederla, di poter fare tutto quello che vogliono. Invece «la violenza schiaccia tutti coloro che tocca e finisce per sembrare estranea sia chi ne fa uso sia a chi la subisce»3: è qualcosa che eccede la volontà dei singoli (ma anche quella dei gruppi) e come una marea tocca (e travolge) gli umani. Come la massa d’acqua che esonda da un fiume o che sale dal mare trascina con sé tutto ciò che incontra, ed è solo un caso se i singoli si trovano con la corrente a favore o contro, così la «forza» agisce sui guerrieri, che perciò credono di essere vincitori o sconfitti senza rendersi conto di quello che sta realmente succedendo sotto la superficie caotica degli eventi, ovvero senza comprendere di essere agiti da qualcosa di irresistibile.
A proposito dei guerrieri, Weil scrive: «Non può accadere che non muoiano. Infatti non considerano la loro stessa forza un quantità limitata, né i loro rapporti con gli alttri un equilibro tra forze impari. Dal momento che gli altri uomini non pongono ai loro gesti quella battuta d’arresto da cui unicamente procede la considerazione degli altri, ne concludono che il destino ha concesso loro qualsiasi licenza negandola totalmente ai loro inferiori e quindi vallo al di là della forza di cui dispongono. Inevitabilmente la oltrepassano, ignorandone il limite. E allora sono in balia del caso le cose non obbediscono più… questo castigo di un rigore geometrico che punisce automaticamente l’abuso della forza ha costituito l’oggetto principale di meditazione presso i greci e costituì l’essenza dell’epopea».4
È il poeta, semmai, che nella sua dolorosa meditazione concepisce «l’idea di un destino comune nel quale carnefici e vittime sono allo stesso modo innocenti: vincitori e vinti fratelli nella medesima miseria. Il vinto rappresenta una causa di sventura per il vincitore, allo stesso modo in cui il vincitore lo è per il vinto».5 È questo che rappresenta il valore della poesia omerica, nota Weil. Gli uomini, tutti gli uomini, sono ugualmente vittime e la vera dialettica è tra loro e la «forza» molto più che tra gli schieramenti militari o politici. Omero nell’Iliade è il solo che riesca a provare pietà in modo uguale per tutti i suoi protagonisti, ogni volta che vengono schiacciati dal fato. Già nell’Odissea questa capacità di stare da ambedue le parti del conflitto si affievolisce, e manca del tutto nell’Eneide, che è scritta a tavolino. I poemi epici cristiani medievali poi non sono capaci di questa compassione, perché partono da una premessa che oggi diremmo «ideologica» (i cristiani possiedono la verità e quindi sono nel giusto, i musulmani per definizione non possono che essere nell’errore).
La schiavitù
Ma la forza non si manifesta in un modo solo e quindi si può trasformare l’uomo in «cosa» in molti modi.
«La forza che uccide è l’aspetto rudimentale, grossolano della forza. Molto più sfaccettata nei suoi processi, molto più sorprendente nei suoi effetti è l’altra forza, quella che non uccide; vale a dire quella che non uccide ancora. È sul punto di uccidere, forse lo farà oppure per adesso incombe sospesa sull’essere che essa in qualsiasi istante può uccidere; in tutti i casi trasforma l’uomo in pietra».6
Weil, seguendo il testo omerico, parla solo degli schiavi, i «più infelici tra gli esseri umani», che «pur senza morire diventano cose per tutto il resto della loro vita. Nei loro giorni, non esiste alcun passatempo, nessuna pausa, nessuno spazio libero per qualsiasi cosa provenga dalla loro iniziativa. Essi non sono uomini che vivono una condizione più dura di altri o che sono collocati socialmente su uno scalino inferiore rispetto ad altri; si tratta di un’altra specie umana, un compromesso tra l’uomo e il cadavere».7
Lo schiavo, ossia l’uomo ridotto a cosa, è spinto fuori dal confine della umanità piena, in una «terra di mezzo» tra la vita vera e la morte. Colpisce nella descrizione di questa vita-non vita il carattere della uniformità e della ripetizione coatta dei gesti, che assomiglia molto alla condizione del proletariato classico del protocapitalismo marxista ma anche a quella degli strati inferiori della forza lavoro di oggi, accomunata alla condizione schiavile dall’aver perso tra le altre cose la capacità di compiere gesti realmente autonomi, ossia di scegliere e decidere sulla propria vita.
Come osserva ancora Weil, «che un essere umano sia una cosa rappresenta già una contraddizione dal punto di vista logico, ma quanto l’impossibile diventa realtà la contraddizione diventa lacerazione dell’animo. In ogni momento, questa cosa aspira ad essere un uomo, una donna, senza mai riuscirci. È una morte che si protrae lungo il corso di una vita, una vita che la morte ha cristallizzato molto tempo prima di averla soppressa».8
Il corpo delle donne
Il discorso della Weil si ferma qui ma noi possiamo proseguire ibridando il suo discorso con i suggerimenti sartriani sul pudore e la oggettivazione del corpo contenuti ne L’essere e il nulla ma anche, in forma poetica, in A porte chiuse per approdare infine nei dintorni del femminismo contemporaneo. Se il gesto anti-etico per eccellenza è trasformare l’uomo in cosa, e se si riconosce che esistono molti modi in cui questo azione si manifesta, si tratta di mappare fenomenologicamente questa sconfinata pluralità di aggressioni dell’umano, nelle quali appunto in «molti modi» si ripropone l’unico delitto capitale, la negazione dell’umano e a sua trasformazione nel suo opposto ossia in una «cosa», in un «oggetto».
La prima categoria in cui possiamo applicare il criterio suggerito dalla Weil (il male è dove si trasforma l’umano in cosa) è quella dei gesti, degli sguardi e delle parole con le quali le donne vengono traformate in oggetto: a partire da quelli apparentemente più innocui del catcalling per passare alle molestie (in tutto il loro spettro, dalla «mano morta» sull’autobus allo stalking fino alla denigrazione del coniuge davanti ai bambini) e arrivare fino alle violenze vere e proprie, in quel tragico climax che sfocia nel femminicidio. Non è un caso che i maschi, ai livelli iniziali di questa catabasi, non capiscano proprio la reazione delle donne: loro vedono solo la parte «attiva», cioè la loro parte, e non comprendono perché le ragazze oggetto delle loro battute, dei loro fischi o delle loro manate «non stiano al gioco». Mentre l’esperienza vissuta dalle donne vittime di queste «attenzioni» spesso parla di un «sentirsi gelare», di un «impietrirsi», di un «bloccarsi» come se fossero vittime di un incantesimo. Non è una strana «magia» che le blocca, ma la percezione oscura della «forza» nel senso della Weil e l’intuizione che precorre e anticipa confusamente quello che sin dall’inizio è il suo bersaglio finale, ossia la cosificazione della persona, il volerna trasformare in oggetto da possedere e in ultima analisi da distruggere come persona. Ma questa intuizione è possibile perché in realtà anche i gesti più piccoli (ossia quelli che i maschi percepiscono come «piccoli») sono già la trasformazione del corpo vivente femminile in cosa, sia pure in una forma diversa dall’uccisione.
Solo una visione astratta può illudersi di disporre secondo una scala di più e di meno la sequenza degli atti che ho appena indicato, scegliendo poi arbitrariamente un livello (sia esso lo sguardo, il fischio, l’insulto, l’invito crasso e sessuale, la pacca sul sedere e così via) sotto il quale «non è successo nulla», «è stato solo scherzo», «volevamo solo divertirci un po’». Così i maschi si autoassolvono ancora prima che ci sia la reazione della donna, dichiarando che il loro comportamento, considerato in sé, come puro gesto, è talmente lontano dal vero attacco da non dover nemmeno essere preso in considerazione.
Il «pudore», in questo contesto, non è la negazione del desiderio sessuale ma la espressione della volontà di non essere ridotte a «cosa». Qui trova il suo fondamento filosofico e antropologico anche la condanna della pornografia, che non è arte proprio perché per essenza vive della «cosificazione» del corpo femminile. Il sexting e il revenge porn perciò non sono gesti futili e leggeri, degli «scherzi» solo un po’ pesanti che non meritano tutto il polverone che le vittime sollevano: proprio al contrario nella società esasperata dell’immagine in cui siamo immersi oggi rappresentano spesso la porta di accesso ai gironi infernali di una oggettivazione del corpo femminile sempre più spinta.
Oltre la violenza
I guerrieri di ogni tempo all’inizio del conflitto sono spavaldi perché sono ancora convinti di poter controllare le energie che stanno per liberare: «al momento della partenza il loro cuore è leggero come lo è sempre quando dalla propria parte c’è una forza e il vuoto dalla parte avversa. Le armi sono nelle loro mani e il nemico è assente. Fatta eccezione per i momenti in cui l’animo è afflitto a causa della grande reputazione del nemico, si è sempre molto più forti di un assente. Un assente non impone il giogo della necessità. Al momento nessuna necessità si affaccia ancora alla mente di coloro per i coloro per i quali è così ed è proprio per questo che se ne vanno come a giocare, per una vacanza, lontani dagli obblighi quotidiani».9
Questo commento di Weil vale per ogni guerra, ma in particolare per la Prima guerra mondiale: milioni di persone di arruolarono volontariamente, come se fosse un gioco. È la intelligetnte spiegazione di un comportamento altrimenti irrazionale, davanti al quale noi oggi restiamo stupiti. L’assenza dell’altro, nei momenti iniziali della mobilitazione, genera l’illusione dell’onnipotenza che è il sentimento più inebriante di tutti. Tutti si sentono forti; tutti chiedono la loro ricompensa in anticipo, come se avessero già vinto. Ma senza una qualche forma di resistenza non si può neanche valutare la propria forza, e si finisce in modo quasi inevitabile a sopravvalutarla, come capitò ai fascisti nel 194. Ci si trova immersi quindi in un bias dalle conseguenze irreparabile, perché ci si accorgerà dei propri errori solo quando è troppo tardi per tornare indietro.
« un uso moderato della forza, il solo che potrebbe permettere di sfuggire a tale meccanismo, richiederebbe una virtù che va oltre l’umano, tanto rara quanto una dignità costante nella debolezza punto del resto neppure la moderazione È priva di rischi: perché il prestigio che per tre quarti compone la forza, è Innanzitutto, costituito dalla superba indifferenza del Forte per i deboli, una indifferenza così contagiosa che si trasmette a coloro che ne sono l’oggetto. Ma un pensiero politico che consigli il eccesso non è cosa comune è la tentazione a risultare quasi irresistibile».10
Conclusione
«Comunque sia,questo poema è una cosa miracolosa. L’amarezza verte sull’unica giusta causa di amarezza, la subordinazione dell’animo umano alla forza, vale a dire, cioè, alla materia. .. Nell’Iliade nessuno visi può sottrarre proprio come nessuno vi si sottrae sulla terra. Nessuno di coloro che vi soccombe è considerato per questo da disprezzare. Qualunque cosa che, nell’animo e nelle relazioni umane, sfugge al dominio della forza è amato, ma amato dolorosamente, a causa del pericolo di distruzione che continuamente incombe»11
Gli uomini quando sono sottoposti alla violenza (sia perché la subiscono sia perché la esercitano) perdono il meglio della loro umanità e scadono al livello delle «cose» in cui vogliono ridurre gli altri uccidendoli: «L’Iliade esprime il segreto ultimo della guerra con i suoi paragoni, dove i guerrieri appaiono simili all’incendio, all’inondazione, al vento, alle bestie feroci, a qualsiasi causa cieca di disastro, quanto ad animali impauriti, alberi, acqua, sabbia e a tutto ciò che è squassato dalla violenza delle forze esterne… l’arte della guerra non è altro che l’arte di dare il via a tali trasformazioni e il materiale, i procedimenti, la morte stessa inflitta al nemico non sono che dei mezzi a tale scopo; il vero oggetto è l’animo stesso dei guerrieri.»12
Ma d’altra parte esiste la possibilità (almeno la possibilità) di un altro modo di vivere, anche se essa si manifesta raramente e in modo intermittente.
«La leggerezza di coloro che usano senza rispetto gli uomini e le cose che hanno o credono di avere alla loro mercé, la disperazione che spinge il soldato a distruggere, l’annientamento dello schiavo e del vinto, i massacri, tutto contribuisce a creare una uniforme immagine di orrore. La forza ne è l’unico eroe. Ne risulterebbe una cupa monotonia se, disseminati qua e là non vi fossero momenti brevi e divini in cui gli uomini conservano il loro animo. L’animo che si risveglia così per un attimo, e poi si perde subito dopo sotto l’impero della forza, si risveglia puro e intatto; non vi appare nessun sentimento ambiguo, complicato o torbido: c’è posto solo per il coraggio e l’amore.»13
«È possibile amare ed essere giusti solo se si conosce il dominio della forza e si è capaci di non rispettarlo»14
Con passaggio molto veloce e non molto fondato Weil paragona questo sentimento a quello del Vangelo, che sarebbe «l’ultima e meravigliosa espressione del genio greco».15
1Simone Weil, Iliade. Il poema della forza, Ricerca filosofica 4, Farina editore, 2016, p. 11.
2Ibidem, p. 32.
3Ibidem, p. 26.
4Ibidem, p. 22.
5Ibidem, p. 26.
6Ibidem, p. 12.
7Ibidem, p. 15.
8Ibidem, p. 16.
9Ibidem, p. 27.
10Ibidem, p. 26.
11Ibidem, p. 38.
12Ibidem, p. 32.
13Ibidem, p. 33.
14Ibidem, p. 39.
15Ivi.